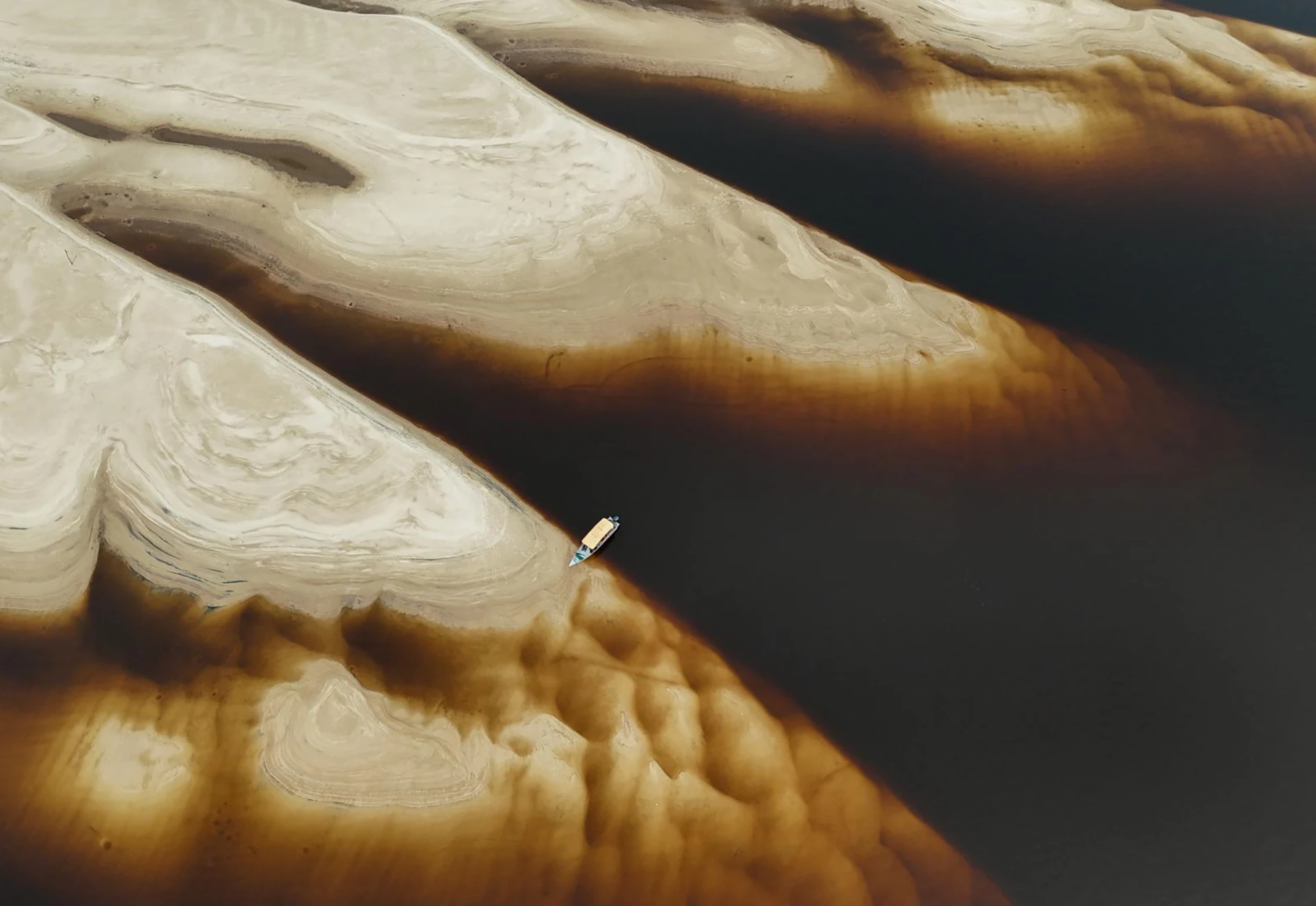
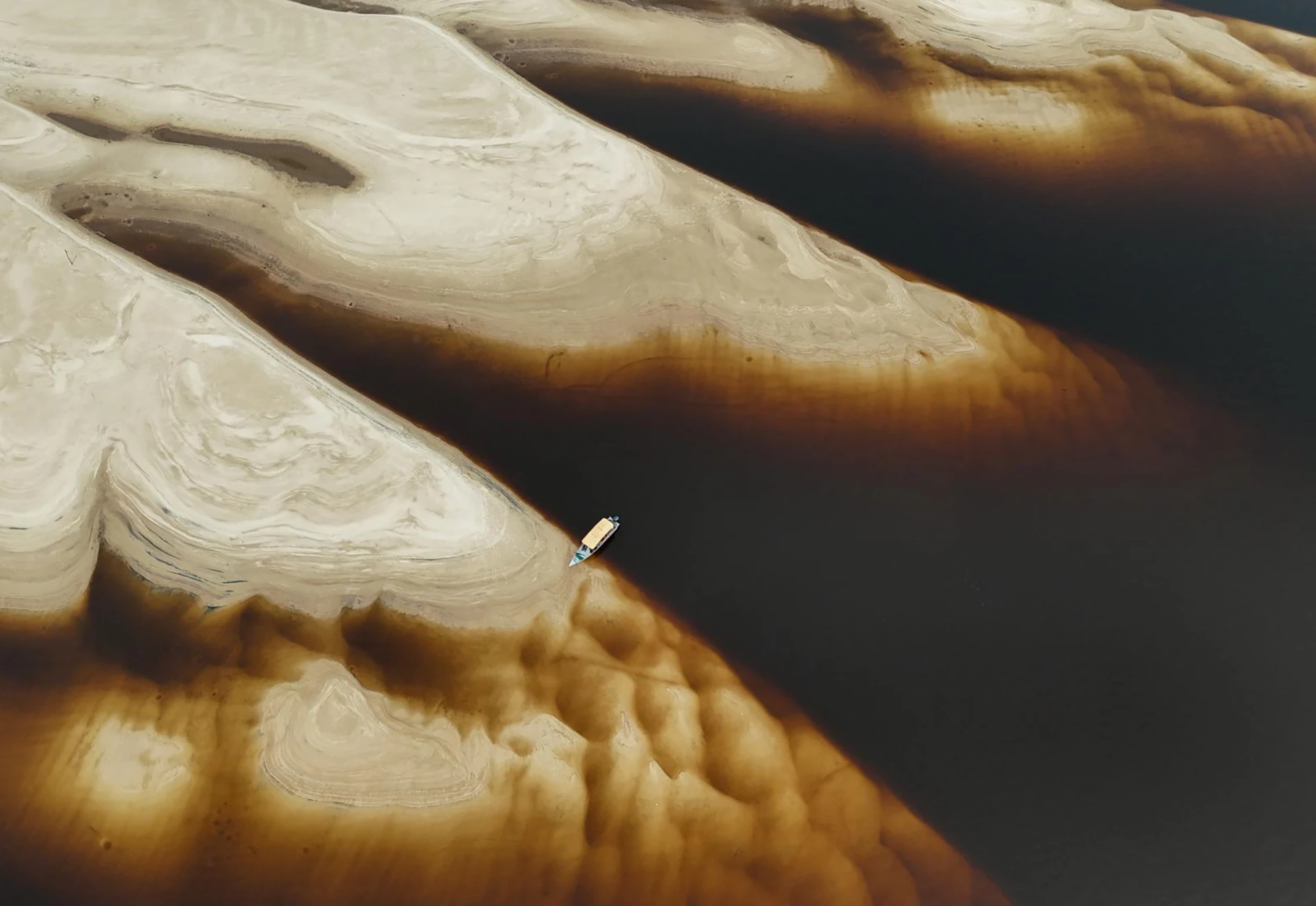
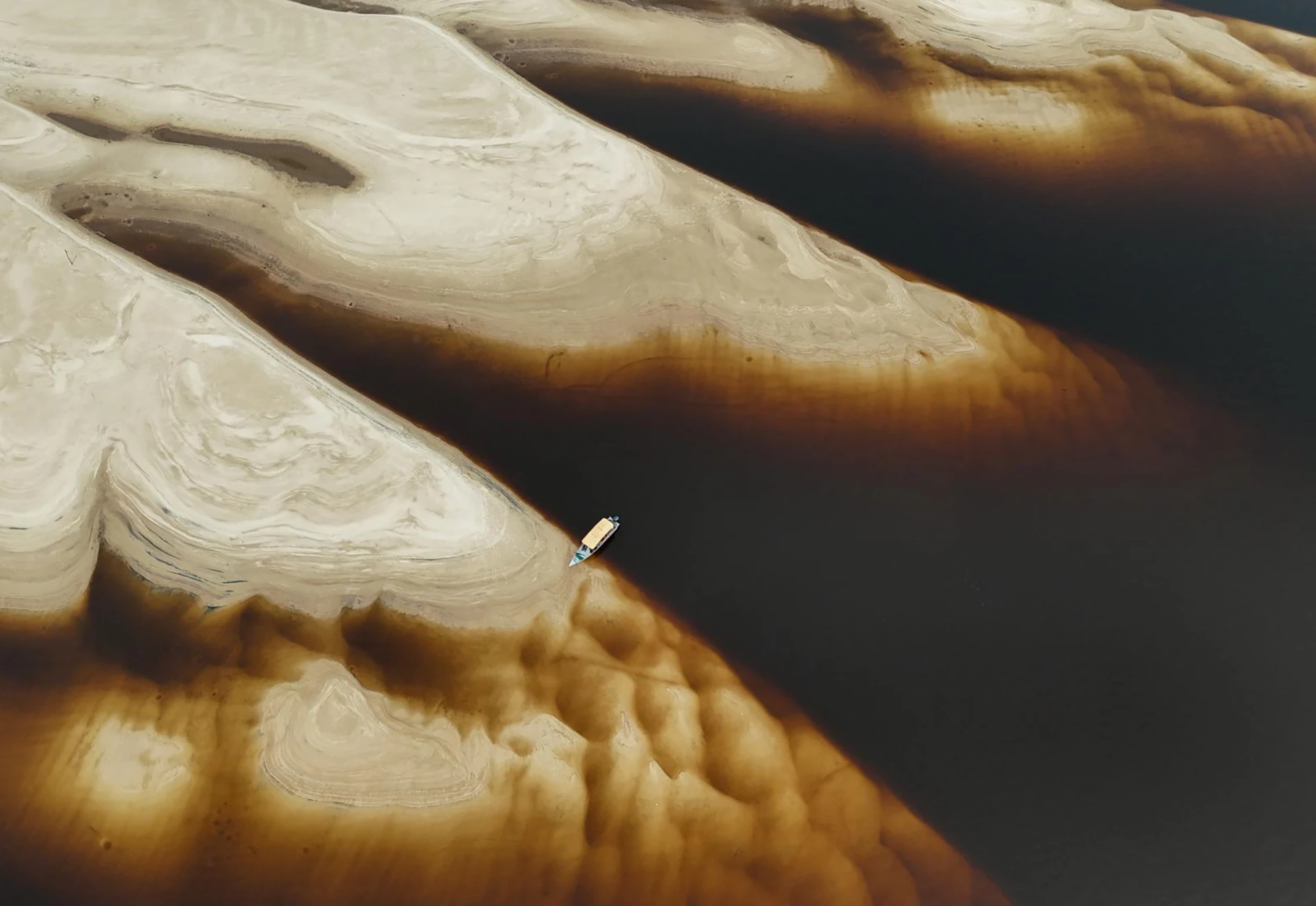
Nel gran dibattito che si è aperto dopo i recenti disastri nazionali, nel coro di allarmi, denunce, critiche, autodifese e proclamati impegni, di una cosa si è assai raramente parlato: cioè dell’esigenza di impostare anche in Italia un’azione sistematica di “conservazione della natura”. Si è parlato di regolazione delle acque, di argini, di erosione, diimboschimenti, di dighe: si è cioè mostrato ancora una volta di credere che la difesa del suolo (e quindi, alla fine, della vita umana) possa essere garantita semplicemente dalla somma dei miliardi e delle singole opere pubbliche, settore per settore, trascurando quella disciplina fondamentale che appunto si chiama “conservazione della natura”: una disciplina complessa che studia nel suo insieme, unitariamente, l’ambiente in cui viviamo, e che, insegnandoci a non alterare insensatamente il prezioso equilibrio delle forze organiche e inorganiche, tende ad evitare che l’uomo, come disse una volta Julien Huxley, diventi il “cancro dell’universo”, con le disastrose conseguenze che sappiamo. Qualcosa, è vero, si è finalmente capito: che la difesa delle coltivazioni, della pianura, della città comincia in montagna, che non serve costruire argini ai fiumi se si distruggono le foreste; tuttavia s’impreca, come Don Ferrante, contro le stelle, ovvero, in maniera ottocentesca, contro la natura matrigna e la sua “furia cieca e brutale”.